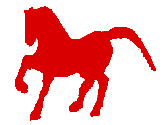Oggi,17 maggio,è la giornata mondiale contro l’omotransfobia, una giornata che non dovrebbe esistere, perché non dovrebbe esistere,nel mondo, l’omotransfobia, che è uno dei più stupidi atteggiamenti che l’umanità possa avere. Stupido credo sia l’aggettivo più adatto per definire chi offende, chi sentenzia, chi ironizza su persone che non sono né diverse, né malate, né immorali. Potrei scrivere tutto un post sulla stupidità di questi sputa-sentenze, loro sì, malati, malati di moralismo, di machismo, di mentalità bigotta. Ma ho deciso invece di ripubblicare un racconto che mi è caro, un racconto che parla di amore, l’amore fra una coppia. Non un amore particolare, un amore e basta, come tutti noi, almeno una volta, abbiamo provato. Una storia come un’altra, insomma. Il racconto è molto lungo, spero che abbiate la pazienza di leggerlo tutto.
Una storia come un’altra
Prima che salisse sul treno l’ho abbracciato forte.Ho preso il suo viso fra le mani e l’ho baciato sulle labbra.
Si è lasciato andare contro di me, per un attimo.
Ho sentito quanto fosse fragile il suo corpo, in quel momento,quasi inconsistente.
L’ho guardato salire in vettura, la valigetta che gli sbatteva nelle gambe, una scarpa slacciata. “Ricordati, sono con te…”, gli ho detto. “Stai tranquillo, io ci sono sempre”, ho aggiunto.
Si è girato e mi ha sorriso, un sorriso appannato. Le porte della carrozza si sono chiuse.
Il piazzale della stazione è già tutto imbiancato da questa precoce neve di fine autunno. Alle fermate degli autobus la gente batte i piedi sul selciato per riscaldarsi e guarda impaziente l’orologio. Forse nevicherà anche a Milano:i giardini di Piazza Bibiena impolverati di bianco dalla neve sottile, che imbiancherà anche la bara, portata a braccia verso l’auto funebre. E con il suo gelo avvolgerà lo smarrimento di Adriano.
Guido lentamente, tornando verso casa, smarrito anch’io, nei miei pensieri.
Adriano l’ho conosciuto nel sole: il primo ricordo è di un ragazzino pallido che si aggirava incerto nel giardino di casa mia, gli occhi socchiusi al riverbero della luce di una giornata ischitana di piena estate. I miei, allora, affittavano alcune stanze ai “forestieri”, come li chiamavamo, che scendevano dal nord ogni stagione a turbare la nostra tranquillità, il nostro vivere lento, a toccare i nostri oggetti, a dormire nelle nostre camere. A ogni estate, mi sentivo defraudato, pensavo che quei “forestieri” ci stavano rubando una stagione della nostra vita, e non riuscivo mai a fare amicizia con nessuno dei loro bambini. Ma così era, e di quei soldi avevamo bisogno.
Con Adriano era stato diverso già dal primo momento. Mi piacquero subito anche i suoi genitori: il padre, alto, magro come il figlio, la madre un po’ rotondetta come la mia, un cespuglio di capelli rossi che le finivano sempre davanti agli occhi nerissimi, gli stessi occhi di Adriano. Tutti e due gentilissimi, cordiali, non arroganti come tanti altri villeggianti che li avevano preceduti.
Lui era professore universitario, lei era giornalista. Io già allora avevo mille domande nella testa, mille dubbi su ciò che era giusto, su ciò che giusto non era; ero una personcina seria, mi dicono i miei, in una casa piena di allegria e risate. Le risposte alle mie domande che la mia famiglia non riusciva a darmi erano compensate da un abbraccio, da un sorriso, da una visione del mondo positiva, anche quando le cose sembravano farsi difficili. Le domande, i dubbi, rimanevano però irrisolti:continuavo a chiedermi perché il mio compagno di banco non portava mai la merenda, a scuola, e vedevo poi sempre sua madre fare la fila davanti all’ufficio di assistenza pubblica del comune; perché il padre di Ciro era dovuto partire per la Germania, dopo il licenziamento dallo stabilimento di Napoli dove lavorava, lasciando a casa quattro bambini piccoli; perché Salvatore Russo era sempre ubriaco e si diceva che picchiasse la moglie; perché i signori che avevano le belle ville arrampicate sulla montagna avevano anche belle barche ormeggiate al porto; perché i “forestieri” venivano da noi in villeggiatura, ma noi non andavamo in villeggiatura da nessuna parte.
Non ricordo come cominciai a parlare di tutto questo con Adriano. Ricordo però quello che lui mi disse: anche a Milano succedevano molte di queste cose,mi disse, ma il suo papà e la sua mamma cercavano di cambiarle: scrivendo articoli, andando a manifestazioni, tirandosi in casa, a volte, persone che avevano bisogno di un alloggio. Madri con bambini, ragazzi giovani, vecchi abbandonati. Lui mi confessò che all’inizio aveva avuto paura di tutta quella gente che spesso piangeva, o lo guardava con sguardi che lui non riusciva a decifrare, o emanava uno strano odore. Poi i suoi lo avevano tranquillizzato: gli avevano detto che con il loro comportamento cercavano di rendere il mondo un po’più giusto e che lui poteva aiutarli non avendo paura.
Quell’estate i giorni passarono velocemente fra bagni in mare, corse sulla spiaggia di Citara, partitelle di calcio nel campetto vicino a casa mia con i miei compagni, cui avevo imposto da subito la presenza di Adriano. La sera mangiavamo in giardino: il cibo profumato preparato da mia madre si miscelava all’intenso odore del gelsomino. La domenica, a finire la cena, c’era sempre la pastiera di cui Adriano e suo padre erano ghiotti. Sembravamo tutti una famiglia: spesso mia sorella piccola si addormentava fra le braccia di Monica, e mio padre e Vittorio si scambiavano sigarette –forti e dal pungente aroma quelle di mio padre, più raffinate quelle di Vittorio- e i discorsi erano pacati e tutti potevamo intervenire e dire il nostro pensiero. Il padre di Adriano parlava di scioperi, su al nord, e di ingiustizie, mio padre parlava della fatica della pesca, di fame. E di ingiustizie. Io ascoltavo con attenzione, finchè gli occhi non riuscivano più a stare aperti. Allora, con Adriano, mi trascinavo a letto: per la prima volta dividevo la mia camera con un “forestiero” senza dovergliela cedere completamente come le estati precedenti a quella, e dover andare a dormire fra mia sorella e i miei, nel loro letto.
Quando arrivò il momento della partenza eravamo tutti un poco tristi, ma ci lasciammo con la promessa di rivederci l’anno successivo e di scriverci. Sia io che Adriano avremmo cominciato a frequentare la prima media, ed eravamo impazienti di scambiarci le impressioni su quella nuova esperienza.
Mi fermo al rosso; penso che devo andare assolutamente a fare la spesa. Ieri, quando è arrivata la telefonata da Milano, stavo scendendo al negozio, ma poi chi ci ha più pensato…
Mentre riparto, l’immagine di Monica mi appare nitidissima, così,come l’ho vista l’ultima volta: i capelli ancora rossi, sempre un po’ arruffati, leggermente appesantita dagli anni, una maschera di sgomento e di rifiuto nel volto, mentre retrocede davanti a noi, nel lungo corridoio della redazione del giornale. No, non era andato bene quell’incontro, anzi, non c’era stato alcun incontro. Ricordo l’espressione livida di Adriano, quel giorno, la stessa di ieri, mentre ascoltava al telefono la notizia della morte improvvisa della madre.
Così, in un certo senso, Monica se ne è andata vittoriosa, senza alzare una bandiera di resa.
Parcheggio sotto casa. Non nevica più, e il freddo è aumentato. Mi infilo nel negozio di alimentari, non so neppure esattamente cosa comprare: quando tornerà Adriano?
“Ciao, Mauro!” Mi saluta allegramente Rosa, mentre finisce di pulire l’affettatrice.
“Ciao, Rosa! Allora… dammi… Sai, non so cosa comprare… Adriano è partito, è andato a Milano, è morta… è morta sua madre, all’improvviso, e non so quando lui torna, sai, le pratiche…”
“Oh, mi dispiace”, dice Rosa, un po’ imbarazzata. Rosa è anche una grande amica e anni fa le abbiamo raccontato la nostra storia. Irruente e genuina aveva espresso pesanti giudizi sui genitori di Adriano e sul loro modo di agire.
“Già”, dico mentre mi guardo intorno. Sul banco sono esposti diversi dolci casarecci: ciambelle, crostate, tortine alla frutta.
“E se gli preparassi la pastiera?” penso fra me. “La pastiera gli piace tanto. Ci riporta all’infanzia, alla casa odorosa dei miei, al calore del sole e dell’abbraccio. La pastiera è consolatoria”.
Sono anni che non la faccio, ma gli ingredienti li so a memoria per aver visto tante volte mia madre misurare tutte le dosi.
Dopo aver richiesto a Rosa gli alimenti che mi servono per la quotidianità, comincio a pensare agli ingredienti che mi serviranno per preparare la pastiera: dunque, zucchero e farina li abbiamo, la cannella pure e anche i limoni…Quindi, vediamo un po’…
“Rosa, mi è venuta voglia di preparare la pastiera. Dammi un barattolo da due etti di grano precotto, un panetto di burro da due etti e mezzo, due confezioni di uova, un litro di latte, ottanta grammi di cedro e arancia canditi e mezzo chilo di ricotta.”
Mentre Rosa mi prepara tutto, entra nel negozio la signora Olivieri, quella del quinto piano. Ho smesso da anni di salutarla, visto che lei non ricambiava mai il mio saluto, e quando mi incontra, e ancor di più quando incontra me e Adriano insieme, storce quella sua vecchia faccia, come se sentisse un terribile cattivo odore. Adriano continua a salutarla, dice che bisogna cercare di capirla. Io invece la odio. Troppe volte ho visto quegli sguardi, quando la gente intuiva che io ed Adriano non eravamo soltanto amici.
Pago, saluto Rosa, oltrepasso la signora Olivieri, che si allontana di scatto, ed esco dal negozio.
Mi sento stanco. Decido di stendermi sul divano, prima di cominciare a preparare la pastiera. Metto un cd nel lettore. Le note della Moldava di Smetana mi hanno sempre rilassato.
* * *
Il treno si è fermato in aperta campagna. Ha ripreso a nevicare, grossi fiocchi che sbattono contro il finestrino, come insetti bianchi. Miei compagni di viaggio una vecchia signora calabrese e suo figlio.
Mia madre non è mai stata vecchia, a dispetto dell’età anagrafica: energica, combattiva, piena di passione. E di contraddizioni.
Quando mi avvertì della morte di mio padre mi disse: “Non sognarti di portare quello, al funerale…”. Lo disse con voce dura e spietata, benché io sapessi quanto fosse lacerata dal dolore per la perdita del compagno e quanto dovesse sentirsi fragile in quei momenti.
“L’Irriducibile” l’aveva soprannominata Mauro. “L’Irriducibile” ora se ne è andata, senza capire, lei che capiva tutti, senza accettare, lei che accettava tutti. Tolleranza zero verso me, verso Mauro, verso la nostra storia. La pena, ma anche il rancore, mi dilaniano.
Il treno riprende il suo cammino, lentamente.
La morte rende tutto irreversibile. Non ci sarà mai una cena a tre: Mauro che le versa un bicchiere di vino, lei che si scosta i capelli dal viso, io che sorrido. O una serata con i suoi colleghi giornalisti, Mauro silenzioso e sereno, lei e io animati e concordi su tutto, sempre pronti a disfare il mondo e a rifarlo, gli amici divertiti dalla rara sintonia fra madre e figlio. O la camera preparata per me e per Mauro da lei, nella sua casa.
Tutto questo, in effetti, c’è stato prima. Prima che le dicessi che io, suo figlio, ero innamorato dell’amico d’infanzia e che avevo deciso di vivere con lui, e che lo avrei anche sposato, se questo fosse stato possibile in futuro.
Avevamo quattordici anni quando ce ne siamo accorti. Uno sfioramento delle mani, casuale, mentre riponevamo le biciclette nello scantinato. Gli occhi negli occhi, un attimo, il cuore che è andato a mille. Niente parole, ma nessun imbarazzo. Solo un grande stupore e finalmente la risposta al nostro stare così bene insieme. Tacitamente abbiamo deciso di ignorare quel lampo che ci aveva attraversato il corpo e lo spirito. Per anni non ci siamo detti nulla. Ognuno di noi ha avuto delle ragazze, ci scambiavamo le impressioni, ma non le emozioni su queste storie, perché emozioni non c’erano.
Abbiamo fatto sempre le stesse scelte, più per stare insieme, che per convinzione. I genitori di Mauro sognavano un figlio avvocato, e neppure a lui questa scelta dispiaceva. E così ci siamo iscritti a Legge tutti e due.
Una volta laureati, una sera, ci siamo guardati bene in faccia e ci siamo detti tutto quello che c’era da dire.
Non mi pentirò mai della scelta che ho fatto. Non vorrei mai scambiarmi con nessun altro. Conosco tante coppie eterosessuali che non hanno niente di quello che noi abbiamo: il capirci con uno sguardo, la gioia con cui ancora apprezziamo lo stare insieme, ancora dopo tanto tempo. Abbiamo cinquant’anni e ci sentiamo veramente una coppia, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, o forse, chissà, anche grazie a quelle. L’unico strappo nero sono stati, inaspettatamente, i miei. Solo mio padre, verso la fine della sua vita, ha cercato di capire, si è finalmente arreso. Ma mia madre no, lei non si è mai arresa alla realtà.
Quel giorno, dopo aver incontrato mio padre, un padre finalmente acquietato, o rassegnato, forse, eravamo andati al giornale, io e Mauro. Lei, quando le avevo detto di noi, mi aveva fatto promettere che non avrei mai portato Mauro con me, ai nostri appuntamenti. Così uscì dalla porta dell’ufficio in fondo al corridoio, e stava sorridendo, convinta che io fossi solo. Penso che ogni volta che ci incontravamo sperasse che le dicessi che la storia era finita, che era stato uno sbaglio, un capriccio, e che io, dopotutto, ero “normale”. Poi lo vide
Si fermò di botto, il volto irrigidito dalla rabbia e dal disgusto. Si voltò di scatto e rientrò nel suo ufficio sbattendo la porta.
È stata l’ultima volta che Mauro l’ha vista, e io l’ho incontrata poi solo al funerale di papà. Forse Mauro è quello che ha sofferto di più, in tutta questa vicenda: ha sofferto per me, per il mio dolore di figlio ripudiato; si è sentito responsabile di una scelta che avevamo fatto insieme e che era comunque fin dall’inizio destinata a compiersi.
Il figlio della signora calabrese si è addormentato, la testa appoggiata sulla spalla della madre.
“È stanco”, mi dice lei sussurrando “Ha lavorato fino a ieri sera tardi nella nostra campagna, e ora stiamo tornando su, perché domattina deve andare in fabbrica. Sa, è caporeparto!”
L’orgoglio le fa brillare gli occhi. Passano storie di sacrifici, di rinunce, di speranze, nel suo sguardo. Le sorrido e penso ancora una volta a mia madre.
Quando Raffaele ci telefonò per dirci che si era ammalato di artrosi, e che non poteva più continuare a fare il pescatore, fu lei a lanciare l’idea che venissero tutti su a Milano, lui, la moglie, Mauro e la sorellina: il portiere del nostro stabile era andato in pensione, e il posto era ancora vacante. Un buon lavoro, l’appartamento a disposizione, più possibilità per tutti loro. Che ironia che proprio mia madre sia stata l’artefice del nostro ritrovarci. Forse, se la sua famiglia non fosse venuta a vivere a Milano, le cose fra me e Mauro sarebbero andate diversamente.
Avevamo tredici anni, ci iscrivemmo allo stesso liceo, e si rafforzò anche l’amicizia fra le nostre famiglie. Passavamo quasi tutte le sere insieme, ancora a parlare, a ridere, a giocare a carte, fregandocene altamente se altri condomini guardavano sprezzanti il professore e la giornalista, tanto amici del portiere, per di più meridionale.
Ci siamo: il treno sta entrando nella buia stazione di Milano. Rientro nel presente. Con angoscia mi rendo conto che fra poco mi troverò davanti il corpo senza vita di mia madre, la sua vitalità che ho sempre conosciuto, di cui per anni mi sono cibato, spenta.
La madre calabrese sveglia dolcemente il figlio.
“Sa”, mi viene da dirle “mia madre è morta ieri, sto andando da lei”.
Mi guarda con dolore e mi stringe le mani con le sue vecchie ruvide dita.
“Le mamme non muoiono mai”, mi dice “ti proteggerà dal cielo”.
Non riesco a risponderle niente, un nodo mi stringe la gola. Prendo la valigetta e mi incammino per scendere.
* * *
Il telefono sta suonando. Mi devo essere addormentato. Per un attimo penso che andrà a rispondere Adriano, poi mi ricordo tutto e mi alzo.
“La casa è piena di gente”, mi dice “Io sono appena arrivato”.
Ha quella voce come di metallo, che sempre gli viene fuori quando c’è qualche cosa che lo fa stare male.
“Ci sono tutti. Sono venuti anche dalla redazione di Roma. C’è Luciano, il suo ultimo editore. Sono tutti sbigottiti. Ancora io non l’ho vista. È in camera sua, ma devo trovare il coraggio per entrare. Mi manca, mia madre, sai, Mauro. Mi manchi. Ti vorrei qui”.
Quando abbasso il ricevitore mi trovo a piangere come un bambino. Anch’io l’amavo, quella donna. Mi ha deluso e mi ha fatto star male. Soprattutto non posso perdonarle di aver fatto soffrire Adriano. Comunque l’amavo, o l’ho amata, ed è stata per me, fino ad un certo giorno, come una seconda madre.
La decisione di parlare ai nostri genitori dei sentimenti che legavano me e Adriano mi intimoriva parecchio. I miei non erano come Monica e Vittorio, me ne resi conto in quel momento. Era gente semplice, gli anni vissuti a Milano non li avevano resi diversi da quello che erano: buoni, generosi, pieni di amore, ma sapere che il loro figlio era… Con quante orribili parole la gente aveva cominciato a definirci: finocchio, invertito, orecchione, frocio, checca… Una ricca gamma di espressioni per irridere una affettività che era comunque onesta e limpida più di tante altre. Come l’avrebbero presa, i miei?
Avevamo deciso di parlare loro separatamente. La mia famiglia era da poco rientrata definitivamente ad Ischia: il calore, il profumo di casa le mancava troppo; nonostante l’amicizia con i genitori di Adriano, non erano mai riusciti ad amare il Nord, il suo grigiore, lo smog, l’odore bagnato dei cappotti in metropolitana, la fretta di tutti.
Così da Bologna, dove eravamo andati a vivere, partimmo: lui per Milano e io per Napoli. Sicuro della reazione positiva dei suoi, Adriano, molto meno sicuro io dei miei. Ma tutti e due sicurissimi del nostro sentimento, e decisi a non mollare per nessuna ragione.
Ricordo ancora il viaggio in traghetto che mi portava all’isola, troppo breve per allentare il tumulto che sentivo dentro. Dall’oblò guardavo le onde del mare, e Capri e Procida che incontravo lungo il tragitto, e mi chiedevo se sarei mai tornato in quei posti, o se i miei mi avrebbero allontanato per sempre.
Invece tutto andò inaspettatamente in modo diverso.
Dopo due giorni arrivò a Ischia, senza preavviso, un Adriano smunto, ancora più magro, gli occhi ancora più grandi nel viso bianco.
“I tuoi?” chiese
“Tutto bene. Sai, hanno detto che l’hanno sempre saputo, che l’avevano intuito da anni; ci sono stati male perché capivano che per noi sarà sempre difficile, ma che è la nostra scelta, e hanno detto che ci vogliono un gran bene”.
Non gli chiesi dei suoi. Bastava guardarlo in faccia. Aspettai che fosse lui a parlarmene. Scendemmo lentamente verso la spiaggia, passammo davanti al campo da calcetto dove da ragazzini avevamo fatto le nostre partite. Era il tramonto, un tramonto che sgocciolava arancio sul mare. Piccoli pipistrelli volavano bassi, in spiaggia due bambini stavano ripiegando i teli da bagno. Si fermò e mi mise una mano sul braccio.
“Non hanno capito. Non capiscono. Sono orripilati. Questo mi hanno detto: Siamo orripilati, ha detto mia madre. Con tutta la loro cultura, con tutta la loro comprensione verso tutti, a noi non ci capiscono proprio. Hanno parlato di schifo, di anormalità. È stato orribile, Mauro”.
È andato avanti per mesi a ripetere tutte le loro frasi, ad analizzarle, a chiedersi come era possibile. Andava su a Milano, e ogni volta che tornava era sempre peggio. Poi, col tempo, ha cominciato a convivere con questo rifiuto, ma troppe volte l’ho sorpreso con un libro o un articolo della madre fra le mani, lo sguardo tormentato.
Alla fine abbiamo cominciato a scherzarci sopra a questa cosa, battute un po’ amare. L’Irriducibile, abbiamo cominciato a chiamarla, lei, sua madre, soprattutto dopo che il padre si era finalmente rassegnato alla realtà.
Andiamo spesso dai miei, giù all’isola. Sono vecchi, mio padre ormai non si muove più, ma il calore con cui ci accolgono è sempre quello di tanti anni fa. Anche noi andremo a invecchiare là, insieme, come hanno fatto mio padre e mia madre, legati come loro, e non c’è nulla di diverso, da un affetto che si fa sempre più profondo.
Mi sciacquo il viso. Mi guardo allo specchio: i capelli sono tutti bianchi, le rughe segnano la storia del tempo che è passato, gli occhi sono arrossati per il pianto, eppure il mio viso mi piace, perché piace ad Adriano, perché mi sento amato. E ho la certezza che sarà veramente “finché morte non vi separi”. Senza cerimonie, senza giuramenti davanti a una qualsivoglia autorità.
Dal bagno sento il campanello di casa squillare.
Rosa ha due pizze e un sacchetto con due bottiglie di birra.
“Stavo troppo male a pensarti qui da solo. Il mio è un atto di puro egoismo”.
Si è ricordata qual è la mia pizza preferita, velocemente prepara la tavola. E io penso che Rosa è veramente un’amica e che è un tesoro. E che non c’è differenza di qualità fra uomini e donne, la differenza è fra le persone, a prescindere dal loro sesso.
“Posso aiutarti a fare la pastiera? La prepariamo domani, che nel pomeriggio il negozio è chiuso”, dice.
* * *
I funerali hanno una funzione catartica, purificano il dolore, lo adattano all’anima.
È finita. La funzione civile è stata breve. Nel piccolo cimitero fuori Milano, dove mia madre ha raggiunto mio padre, la gente arrivava fin nella strada. Non ci sono stati fiori, ma qualche piccola bandiera rossa, e un ragazzo del centro sociale che ha cantato Paolo Conte, per l’ultima volta, per lei.
“Un’altra vita per noi
oltre il basilico e la sua fragranza
……………
un’altra vita verrà
e un’altra vita sarà
oltre le lune e gli uragani”
Mamma, non ci sarà un’altra vita per poter capire. Non solo io, non solo Mauro, ma anche tu hai perduto tanto, anche tu. Te ne sei mai resa conto?
I funerali hanno una funzione catartica. Chiudono un periodo. Dopo un funerale è come se si cominciasse ad intravedere una strada, davanti, anche se piena di buche, di ostacoli, di filo spinato. Ho sempre pensato così, anche dopo il funerale di mio padre; ma in questo momento, seduto qui sul letto di mia madre, non vedo nessuna strada davanti a me. Il periodo non può essere concluso, senza la comprensione, senza l’accettazione.
C’è ancora un’ombra del suo profumo, i suoi post it sparsi dappertutto, appunti scritti a mano a mano che un pensiero le veniva alla mente. Ne era sempre piena la casa. Solo sul comodino ora ce ne saranno una decina. Comincio a leggerli. Alcuni sono incomprensibili, per me: frasi spezzettate, parole isolate. Poi: “Adriano, leggi fra i miei documenti nel computer”. La calligrafia è tremolante, le tre righe che compongono la frase sono tutte di sghimbescio: di solito lei è, era, ordinatissima, con una grafia arrotondata e ferma. È certamente l’ultima cosa che ha scritto, l’ultimo suo appunto. L’hanno trovata morta nel suo letto.
* * *
Ha telefonato Adriano. Arriverà questa sera, con l’Eurostar delle 20. Mi è sembrato più tranquillo, più sereno.
Oggi è meno freddo, c’è un sole opaco che cerca di scaldare i vetri delle finestre.
Mentre aspetto Rosa comincio a preparare sul tavolo di cucina tutti gli ingredienti per la torta.
Apro la scatoletta di grano, misuro due decilitri di latte, peso duecento grammi di zucchero, e trenta grammi di burro. Questo per il ripieno. Per la pastafrolla preparo due etti di farina, un etto di zucchero, un etto di burro. Poi ripongo in frigorifero le dosi di burro, perché non si sciolga nell’attesa.
Quando Rosa arriva ci suddividiamo i compiti: lei preparerà il ripieno e io la pastafrolla. Mi dice di mettere su un cd di canzoni napoletane, per sentirsi più ispirata. Così cominciamo a lavorare con il sottofondo di “Reginella” e “Core ingrato”.
Verso i due etti di farina sul ripiano di marmo del tavolo, con un cucchiaio di legno lavoro il burro per ammorbidirlo. Intanto Rosa ha messo in un tegamino il grano, il latte, la scorza grattugiata di un mezzo limone e i trenta grammi di burro.
“Ora fai cuocere tutto per dieci minuti”, le dico, “e mescola sempre. Deve venirne fuori una specie di crema. Sai, mia mamma adopera ancora il grano crudo, e lo fa ammorbidire per giorni nell’acqua. Ma per fortuna con questo precotto si fa molto prima”.
“O.K., Chef, ricevuto! Anche se credo che ci sarà una bella differenza con la pastiera di tua mamma!” E mi fa una piccola carezza sui capelli.
Rosa ha il corpo forte e massiccio e sembra occupare tutta la minuscola cucina, ma penso che siano soprattutto il suo cuore e la sua generosità a riempire gli spazi.
Verso il burro sulla farina, insieme con tre tuorli d’uovo, lo zucchero e un pizzico di sale. Comincio a impastare con delicatezza, la pasta dovrà risultare alla fine soda e omogenea, e mi ci vorrà un po’ di tempo e un po’ di pazienza.
Rosa ha messo a raffreddare la crema di grano sul balcone. Ora sta amalgamando la ricotta con lo zucchero, la scorza grattugiata del rimanente mezzo limone, un pizzico di cannella e un po’ di sale. Ogni tanto interrompe il suo mescolare e mi chiede, mostrandomi la ciotola:
“Va bene, così?”
Ma l’impasto è ancora granuloso e non cremoso come deve diventare.
La mia pastafrolla sembra invece ormai a buon punto. Ne faccio una palla, la infarino e la metto in frigo, avvolta in un tovagliolo. Fra circa mezz’ora dovrò toglierla.
Rosa, continuando a mescolare, ha cominciato a cantarellare seguendo le canzoni del cd. Ha una voce fresca e piacevole. La vita non è stata facile, per lei: varie tristi storie d’amore finite male, poi finalmente il matrimonio, stroncato dopo pochi mesi da un incidente stradale. Eppure è una donna che trasmette allegria e calore, che non cade, che aiuta. Una donna e un’amica vera.
L’impasto che ha preparato Rosa è ora cremoso e liscio. Tolgo quattro uova dal frigorifero, separo i tuorli dagli albumi, e mentre Rosa aggiunge tre rossi alla crema, io monto a neve gli albumi.
“Adesso devi anche aggiungere i canditi tritati, la crema di frumento e continuare a mescolare. Poi ti darò gli albumi appena avrò finito di montarli”, le dico.
Il ripieno è pronto, è ora di passare al compito più difficile, almeno per me: stendere la pastafrolla. Non ho mai capito perché a mia madre riesca così bene. A me si spezzetta tutta, e finisco sempre con il riempire la tortiera con un puzzle di pasta. Però, miracolosamente, cuocendo sta tutto insieme, così non mi faccio troppi problemi.
Fodero dunque lo stampo imburrato con i pezzettini di pasta (dopo averne messo un po’ da parte per le striscioline che ricopriranno la torta), mentre Rosa mi guarda con aria decisamente scettica.
“Dai, versa il ripieno nella tortiera! È o non è un lavoro di squadra, il nostro?”, le dico. Le do un buffetto sulla guancia, e una traccia di farina le rimane sul viso.
Spennello con il tuorlo d’uovo rimasto le striscioline di pasta adagiate a grata sul dolce.
Rosa apre lo sportello del forno, io introduco la torta, predispongo il timer da lì a un’ora e sistemo la temperatura sui 180 gradi.
“Ecco fatto! Pensi che ora non ci meritiamo un caffé? Lo faccio io, Rosa, tu siediti qui. Mi piace la tua compagnia, lo sai, vero…”
Mentre il caffé si sta preparando, riordino in fretta la cucina. Anche nel menage della casa non ci sono stati mai problemi fra me e Adriano. Ognuno fa quello che più gli piace o che gli riesce meglio, e la suddivisione dei compiti è facile e scorrevole.
Adriano.
“Dovrebbe già essere sul treno”, dico “Vuoi cenare con noi, stasera, Rosa?”
“No, penso che è meglio che stiate da soli. Semmai domani sera. E lasciami un pezzo di pastiera, sai!”
* * *
Ci sono pochi viaggiatori sul treno. Il mio posto è vicino al finestrino. Mi siedo e appoggio la fronte al vetro. Mi sento frastornato. Questa notte non ho dormito molto. Ma non è solo la mancanza di sonno che mi fa sentire come sospeso e leggero. Mi tocco la tasca interna della giacca. Sento frusciare la carta. Tre fogli, l’eredità di mia madre.
Il treno si mette in moto, lascia la stazione. Le luci della città mi scorrono davanti agli occhi sempre più velocemente. Una ragazza si siede davanti a me e mi sorride. Mi viene in mente la madre calabrese, mia compagna di viaggio l’altro ieri: “Le mamme non muoiono mai, ti proteggono dal cielo.”
Non so se c’è un cielo da dove le madri ti proteggano, ma so che mia madre è vivissima in me, è vicina quasi a toccarmi. Da ieri sera.
Il documento è di quattro giorni fa. La luce azzurrina del computer si fonde con la vecchia lampada dalla calda luce dorata che lei ha avuto da sempre sulla scrivania.
Il titolo del documento è “Per Adriano e Mauro”.
Il cuore comincia a battermi più in fretta. Un leggero sudore mi inumidisce la fronte. Le mani hanno un lieve tremito. Con il mouse vado all’icona “apri”, ma non clicco. Può esserci di tutto, lì dentro: resa, comprensione, maledizione, di tutto. E senza aver più la possibilità di controbattere, di confutare. Per un attimo penso che sarebbe saggio spegnere il computer e andarmene a dormire.
Ma il dito preme, il documento si apre e leggo in fretta:
“Adriano, Mauro, da qualche giorno non mi sento bene. Mi sento molto stanca, mi duole lo stomaco e ho come un peso sul cuore. Non voglio andare dal medico, spero che passerà così. O forse, sapete, la verità è che non mi interessa molto più vivere. Ma una cosa, se dovessi morire fra poco, ve la voglio, ve la devo dire.”
Mi fermo. Impedisco allo sguardo di andare oltre. Penso a quella frase: non mi interessa più vivere…
Mi alzo. In cucina mi verso un bicchier d’acqua. Scosto le tende della finestra. Fuori è buio. Solo la pallidissima luce dei lampioni della piazza piove sulle cime dei platani, nudi delle loro foglie.
Mamma, se tu avessi accettato la mia relazione con Mauro, una gran parte della tua vita sarebbe stata differente… Noi non potevamo essere diversi da come siamo: perché non lo hai capito?
Ritorno nello studio. Il salvaschermo mostra una mia fotografia scattata tanti anni fa durante una vacanza. Di certo non me lo aspettavo, questo, e mi soffermo a guardare un “io” molto più giovane.
Non sapevo neppure che mia madre l’avesse, quella foto, e mi stupisce veramente che l’abbia messa lì, e che l’abbia tenuta chissà da quanto tempo sotto gli occhi. Ed è come se si aprisse uno spiraglio, un canale di comunicazione fra me e mia madre. Ho meno paura, ora, di proseguire la lettura.
L’ho letta una volta sola, poi l’ho stampata e me la sono messa in tasca. La notte è passata lentamente; a occhi aperti ho rivissuto tanti episodi, tanti flash di vita, così come sono stati e come potevano essere. Ma importante è che ieri sera è stato come se mia madre mi parlasse, e io parlassi con lei, senza ostacoli. E così, alla fine, il rammarico ha piano piano fatto posto alla consolazione, a una sorta di liberazione.
Ho pensato a Mauro. A come avrebbe reagito.
Quando stamattina gli ho telefonato non ho voluto parlargliene. Voglio leggergli questa lettera seduto sul divano vicino a lui, in casa nostra, tenendogli la mano. Voglio guardarlo in viso dopo che avrò letto:
“In questi ultimi tempi ho capito quanto avevo sbagliato. Non mi sono più riconosciuta in quell’atteggiamento che avevo avuto per anni nei vostri confronti. Proprio io, che mi era battuta per tutte le cause, che avevo sempre lottato contro la gente piena di pregiudizi. Proprio io. Proprio io, con mio figlio, con i miei figli, mi sono comportata in maniera ignobile. La ragione? Non so spiegarvela. Forse perché mi sono sentita colpita direttamente; forse anch’io, piccola povera donna, sognavo nipoti che mi rendessero immortale. Ma so che ogni volta che vi pensavo insieme mi sentivo torcere lo stomaco. Solo dopo la morte di Vittorio ho cominciato a riflettere. Lui, prima di morire, mi aveva parlato a lungo; mi aveva pregato di accettarvi. Così, come eravate. Così, come siete. Persone non diverse da me, anzi, probabilmente migliori di me.”
Molte altre parole ha scritto mia madre. Traspare dolore, rabbia verso se stessa per non averci detto prima tutto questo. Ma ha scritto che si sentiva come bloccata, non per orgoglio, o altro, ma perché pensava che fosse assolutamente troppo tardi per ricostruire qualcosa.
“Mi sento come se avessi perso una guerra e intorno vedo solo macerie, e il tempo della ricostruzione è vago, e tutto sembra ormai inutile.”
* * *
Lo vedo scendere dal treno e guardarsi intorno. Gli faccio un cenno con la mano e gli vado incontro. Il suo viso si illumina, ci abbracciamo, per un momento le nostre parole si accavallano. Poi stiamo in silenzio, mentre ci avviamo verso l’auto. Lo sento rilassato, seduto accanto a me, mi infonde un senso di serenità che non mi aspettavo, al suo ritorno.
“Ho qualcosa da farti vedere”, mi dice. “È una specie di regalo, un bel regalo. Ma dopo, a casa”.
Sono incuriosito, ma so che Adriano ha i suoi tempi: non bisogna insistere per farsi dire le cose che ha dentro, non bisogna aggredirlo con domande. Inutile anche chiedergli come è andato il funerale, chiedergli delle sue emozioni. Quando vorrà raccontarmi mi dirà tutto, come succede sempre.
I tre fogli sono appoggiati sul ripiano del tavolino, vicino alla pastiera ancora intatta. Nelle ultime righe che Monica ha scritto per noi la sua tensione, la sua disperazione si è come allentata.
“Ma forse non è troppo tardi. Qualunque cosa mi succeda ho finalmente scritto quello che volevo dirvi da tempo. Mi sembra che il peso sul cuore si sia alleggerito. Forse ho ancora mille anni da vivere, mille anni per vederci, per ridere e discutere, per amarvi tutti e due e gioire del fatto che mio figlio ha uno splendido compagno. E se non sarà così, pazienza. Sarò da qualche parte (ci sarà una sorta di paradiso per gli atei?…) e vi proteggerò. Sapete, ragazzi, penso che questa sia la cosa migliore che io abbia mai scritto. Senz’altro la più giusta. Ciao. Vi abbraccio.”
Alla fine della lettura la voce di Adriano è diventata roca, i nostri occhi lucidi. Ci guardiamo e ci rendiamo conto che solo ora possiamo essere finalmente in pace.
Stiamo in silenzio, la mano nella mano. Poi:
“Sentiamo la tua pastiera?”, mi chiede.
(Da Donne, ricette, ritorni e abbandoni, Pendragon 2005)
Discorso di un deputato argentino (alla faccia dei nostri miserevoli e stupidi Giovanardi & C.)
 Vi voglio raccontare una cosa di piccolo Teo. Eh, lo so che i miei pochissimi lettori superstiti diranno: Ma ancora? Ancora parli del tuo nipotino? Ormai i post di questo tuo blog, che qualcuno, una volta, aveva definito onnivoro, hanno cadenza semestrale, e poi, quando ne pubblichi uno, non scrivi più di politica, o di letteratura, o di attualità, come facevi un tempo. Ma sempre sempre sempre parli di questo Piccolo Teo! Uffa! Ebbene sì… Scrivere di politica e di attualità mi ha stancato, mi disgusta, mi rattrista. La letteratura continuo ad amarla, ma ci sono blogger molto più bravi di me in grado di parlarne.
Vi voglio raccontare una cosa di piccolo Teo. Eh, lo so che i miei pochissimi lettori superstiti diranno: Ma ancora? Ancora parli del tuo nipotino? Ormai i post di questo tuo blog, che qualcuno, una volta, aveva definito onnivoro, hanno cadenza semestrale, e poi, quando ne pubblichi uno, non scrivi più di politica, o di letteratura, o di attualità, come facevi un tempo. Ma sempre sempre sempre parli di questo Piccolo Teo! Uffa! Ebbene sì… Scrivere di politica e di attualità mi ha stancato, mi disgusta, mi rattrista. La letteratura continuo ad amarla, ma ci sono blogger molto più bravi di me in grado di parlarne.
 E fin qui, va be’, niente di eccezionale, direte.
E fin qui, va be’, niente di eccezionale, direte. Capito, le strategie di Piccolo Teo?
Capito, le strategie di Piccolo Teo?